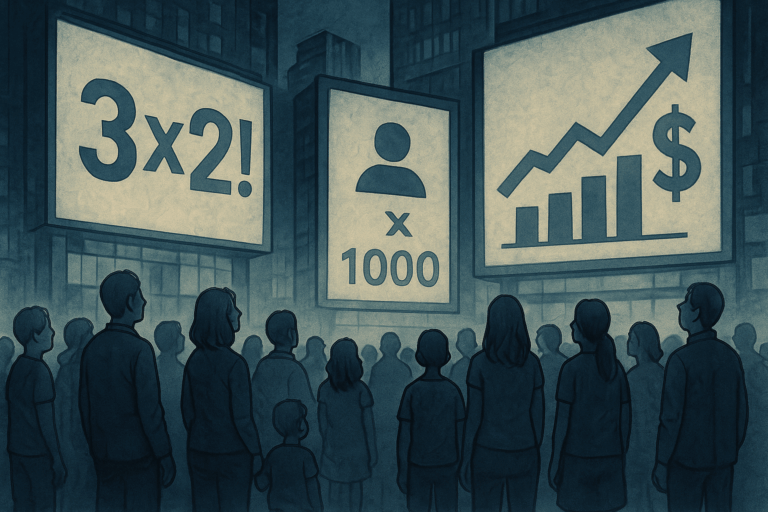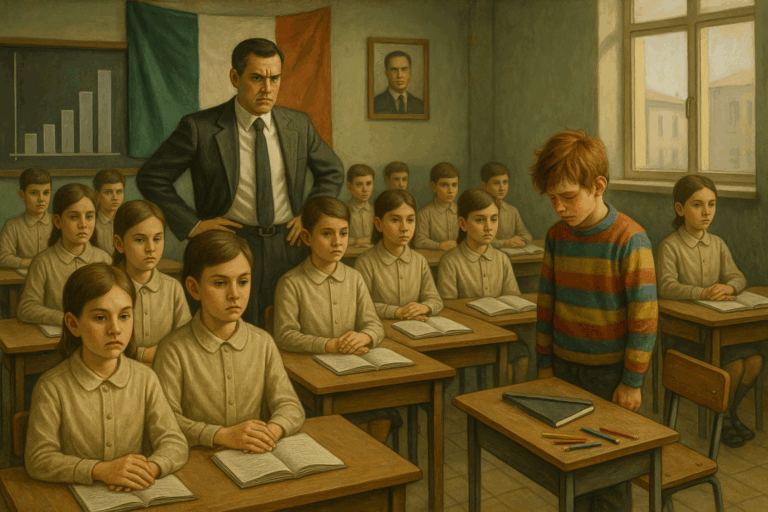Scrivo all’indomani della digestione amara dei risultati del referendum dell’8–9 giugno 2025. Scrivo da cittadina italiana, con addosso un senso di responsabilità che non riesco a scrollarmi di dosso, consapevole del privilegio che la mia cittadinanza mi conferisce in un sistema-mondo ancora profondamente segnato da strutture di potere coloniali.
Chiedo scusa. Scusa a tutti quei giovani — italiani e stranieri — che oggi vivono in un Paese che ha smarrito il coraggio dell’inclusione, e con esso anche la speranza. Un Paese che fatica a riconoscere e smantellare le proprie strutture di privilegio, e che resta impermeabile alla necessità di mettere in atto pratiche capaci di promuovere una giustizia sociale autentica e trasformativa.
Uno dei quesiti del referendum proponeva di ridurre da 10 a 5 anni il tempo minimo di residenza per poter richiedere la cittadinanza italiana. Ebbene, non solo il quesito non ha superato il quorum, ma ha anche registrato il più basso numero di voti favorevoli tra tutti. Il tema della cittadinanza è stato il meno sentito, il più ignorato, come se l’appartenenza a una comunità potesse continuare a essere stabilita da un criterio arbitrario ed ereditario.
Secondo alcune stime diffuse da istituti di ricerca come Ipsos e Demopolis, la partecipazione al voto è stata leggermente più alta tra le donne rispetto agli uomini. Sebbene non si tratti di dati ufficiali, più che spesso è proprio chi vive in prima persona la negazione dei diritti – come le donne – a percepire meglio cosa significhi essere messi un passo indietro. Vorrei chiedere scusa anche a nome di quella parte della popolazione adulta maschile che, pur avendo maggior potere e voce, non ha sostenuto una causa tanto vitale.
Eppure, come sottolinea Paolo Bonetti nell’Osservatorio Costituzionale, quella proposta non rappresentava alcuna rottura drammatica: essa ripristinava semplicemente i cinque anni di residenza già previsti dalla legge italiana dal 1912 al 1992, e che sono tuttora previsti nei principali Stati europei a forte immigrazione. Il nostro rigetto, allora, non è stato giuridico, ma profondamente culturale: il rifiuto dell’idea che si possa diventare “italiani” vivendo, partecipando, contribuendo, e non solo ereditando.
Bonetti nota anche come il titolo stesso del quesito referendario fosse giuridicamente opinabile, in quanto faceva riferimento ai “cittadini extracomunitari”, una categoria ormai priva di fondamento giuridico da quando la Comunità Europea è stata sostituita dall’Unione Europea. Parole sbagliate producono pensieri sbagliati, e questo uso improprio del linguaggio istituzionale non è neutro: è una forma di esclusione mascherata da norma. Se questo è il risultato che abbiamo raggiunto, allora dobbiamo riconoscere che non abbiamo solo fallito nel merito, ma anche nel metodo, perché abbiamo permesso che il linguaggio alimentasse paure anziché chiarire i termini della questione.
Chiedo scusa, dunque, per «come» abbiamo posto la domanda, oltre che per «cosa» abbiamo (o non abbiamo) scelto.
L’abrogazione referendaria, come illustrato nell’analisi costituzionale, non avrebbe introdotto automatismi, ma semplicemente accorciato i tempi per l’avvio del procedimento amministrativo per l’acquisizione della cittadinanza. Il termine di cinque anni sarebbe diventato la soglia generale per i cittadini extraUE, senza intaccare le condizioni già più favorevoli per altri gruppi. Nessun diritto sarebbe stato tolto ai minori, perché la legge già prevede diverse vie per l’acquisizione della cittadinanza da parte loro.
Un aspetto forse non noto a molti italiani che hanno votato (o che hanno scelto di non farlo) è che l’abrogazione avrebbe migliorato anche la situazione per i rifugiati. Oggi, per loro, il termine dei cinque anni decorre dal riconoscimento dello status di rifugiato — che può avvenire molto tempo dopo l’arrivo effettivo in Italia. Con la riforma, quei cinque anni sarebbero stati contati dalla residenza regolare. Non è una sottigliezza: è tempo di vita, di stabilità, di possibilità anticipate. E lo stesso vale per i figli minori conviventi, che avrebbero potuto acquisire la cittadinanza più rapidamente attraverso il genitore naturalizzato.
In molti altri Paesi europei, il termine per poter richiedere la cittadinanza varia, ma spesso è più breve o simile a quello proposto dal referendum. In Francia, ad esempio, la cittadinanza può essere richiesta dopo 5 anni di residenza, o solo 2 anni in caso di integrazione eccezionale. In Germania, con la riforma del 2024, il periodo richiesto è sceso da 8 a 5 anni, e può essere ulteriormente ridotto a 3 in caso di comprovata integrazione. Anche nei Paesi Bassi, in Svezia, in Portogallo e in Irlanda esistono modalità semplificate per chi vive da tempo e si è integrato.
Questo dimostra che il nostro referendum non proponeva un’eccezione radicale, ma un riallineamento con una visione europea della cittadinanza, più inclusiva e attenta ai percorsi di vita reale.
Ma tutto questo è stato oscurato da una campagna tiepida, da un linguaggio sbagliato, e da una colpevole indifferenza. Chiedo scusa anche per non aver saputo — come comunità — informare, spiegare, condividere questi dati. Perché forse, se molti avessero saputo, avrebbero scelto diversamente.
Chiedo scusa per quel silenzio elettorale che ha avuto più forza delle parole, per quella partecipazione mancata che ha tradito chi attendeva da anni un riconoscimento semplice: “sì, anche tu appartieni”.
E chiedo scusa anche per il linguaggio che usiamo, che continua a parlare di “extracomunitari” e di “seconde generazioni” — come se ci fosse un ordine gerarchico ereditario da rispettare, un sangue “più legittimo” di un altro. Ma i figli/e nati/e e cresciuti/e in Italia non sono “seconde” a nessuno: sono cittadini/e nei fatti, solo che il diritto ancora non lo ammette.
La cittadinanza è molto più che un passaporto. È riconoscimento legale, dignità, partecipazione. E la dignità è una conquista fatta di molte tappe:
- Avere un contratto regolare e condizioni di lavoro eque
- Accedere a scuola, sanità, casa come ogni altro cittadino
- Essere rappresentati politicamente
- Essere riconosciuti per ciò che si è, non per da dove si viene
- Essere visti e nominati nel linguaggio pubblico e istituzionale
Eppure nel dibattito politico, le persone migranti continuano a essere trattate come “merce” utile: buone quando servono a noi, invisibili o espulse quando non servono più.
Una logica brutale, produttivista, che ricorda quella della “cultura dello scarto” denunciata da Papa Francesco: ciò che non è utile, si elimina. Una società che misura il valore umano in base alla sua utilità economica è una società profondamente disumanizzante. Quando il criterio dell’efficienza prevale su quello della giustizia e della solidarietà, a essere scartati sono sempre i più vulnerabili: chi non ha documenti, chi non ha voce, chi non ha visibilità. Ciò che non viene nominato scompare. E chi non ha voce non esiste nel dibattito pubblico. Negare la cittadinanza significa dire: “tu non sei parte di noi”.
Ma se non riconosciamo l’umanità, di cosa parliamo quando parliamo di democrazia?
Forse queste parole non possono cambiare il passato. Ma tacerle sarebbe ancora peggio. Questa lettera è anche un impegno: continuare a costruire un Paese in cui nessuno debba più attendere il permesso per essere riconosciuto come parte del tutto.

-

Psicologa-psicoterapeuta perfezionata in Psicologia dell'orientamento alle scelte scolastico-professionali e ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università di Padova. Docente di "Psicologia dell'inclusione e della sostenibilità sociale" e di "Career Counselling e orientamento professionale in contesto multiculturale". Dal 2009 collabora con il Laboratorio La.R.I.O.S. all'organizzazione e all'attuazione di progetti di orientamento, e alla realizzazione di ricerche relative al tema delle vulnerabilità, dell'orientamento e dell'inclusione lavorativa. È membro del comitato direttivo del Laboratorio La.R.I.O.S., vicepresidente della Società Italiana di Orientamento (SIO) ed è membro dell'Advisory Board dell'International Journal for Educational and Vocational Guidance. Attualmente è coordinatrice del progetto europeo Equi-T (sistema europeo di sviluppo della qualità per l'educazione inclusiva e la formazione degli insegnanti).