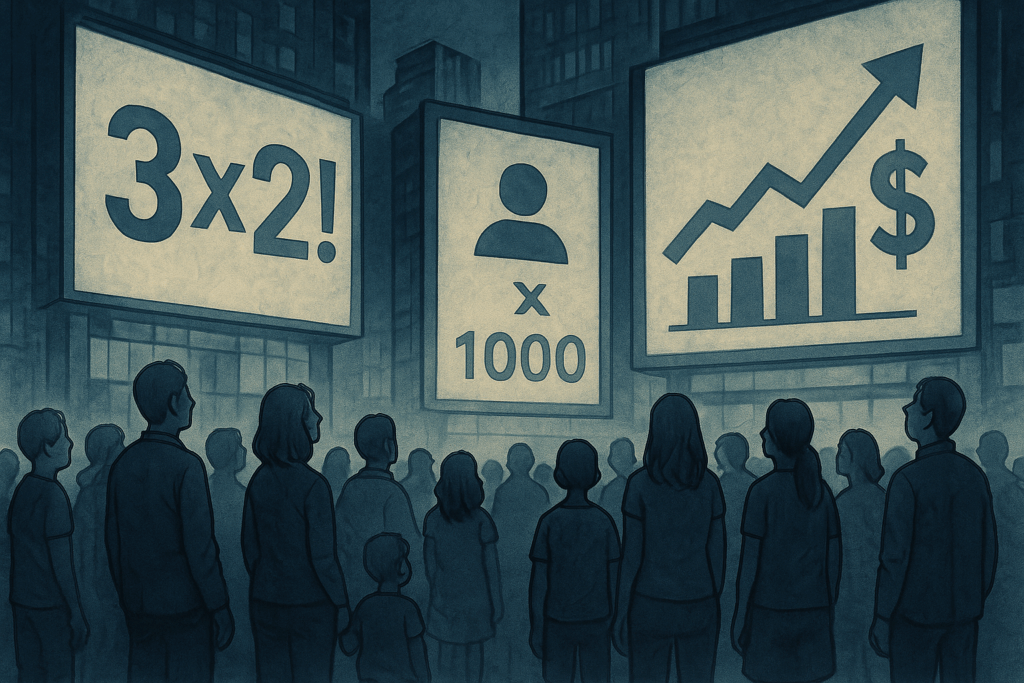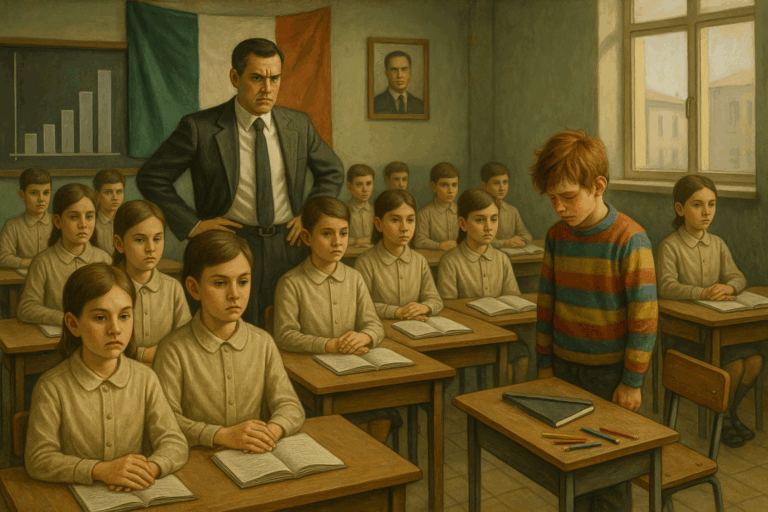Parlare di giustizia sociale e inclusione, oggi, suona ancora per molti come un discorso “di contorno”. Una questione morale, non scientifica. Nei contesti più tecnici o accademici si sente dire che “non sono temi HARD”. Tradotto: non misurabili, non replicabili, quindi poco affidabili. Poco utili. Poco rilevanti.
Eppure, la giustizia sociale è ovunque – anche se raramente appare nei grafici o nei brevetti. È nei contratti precari, nei quartieri dove l’autobus non passa la sera, nelle scuole dove il voto pesa più del contesto.
Ma proviamo per un attimo a capovolgere il discorso:
Cosa succede se parliamo di informatica senza parlare di giustizia sociale? Otteniamo algoritmi che discriminano nel reclutamento del personale (Buolamwini & Gebru, 2018).
E se parliamo di intelligenza artificiale senza inclusione? Rischiamo tecnologie “neutrali” solo in apparenza, che replicano e amplificano i bias già presenti nella società.
E se parliamo di medicina senza equità? Otteniamo sistemi sanitari che curano meglio chi è già privilegiato, lasciando indietro chi ha più bisogno.
In altre parole: anche le scienze dure diventano fragili se ignorano le disuguaglianze.
E infatti, secondo il Pew Research Center (2023), meno del 30% dei programmi universitari STEM integra in modo sistematico temi di giustizia sociale. Eppure, se vogliamo davvero innovare, dobbiamo imparare a considerare la disuguaglianza come una variabile.
E allora, per provocazione e necessità, trasformiamo la giustizia sociale in un problema matematico. Non per ridurla a numeri, ma per dimostrare che senza le giuste operazioni… l’equazione non torna. Somma e sottrazione: le prime operazioni che impariamo da bambini, e le uniche che continuiamo a usare con una certa naturalezza. Sono accessibili, umane, relazionali. Si usano per aggiungere un amico alla chat o togliere zucchero dal caffè. Sono operazioni quotidiane, intuitive.
Ma la società, si sa, ama la moltiplicazione. I pani, i pesci, i follower. Più è meglio. Più dati, più guadagni, più like. Come se tutto il senso della vita fosse racchiuso in un 3×2 del supermercato.
Sì, perché la moltiplicazione e la divisione si usano spesso negli sconti capitalisti, e molto meno nelle politiche pubbliche. “Compra tre, paghi due!” — non “Ottieni uno, redistribuisci l’altro”.
Quando si tratta di profitti, la moltiplicazione è un imperativo. Quando si tratta di diritti, la divisione è un problema. Perché moltiplicare le risorse sembra virtuoso, ma dividerle equamente è rivoluzionario.
Viviamo in un’epoca in cui il benessere globale continua a crescere, ma non per tutti. Secondo Oxfam (2024), l’1% più ricco ha accumulato quasi il doppio della ricchezza del restante 99% nell’ultimo decennio. Non è una disfunzione del sistema: è il sistema.
La retorica della moltiplicazione domina: più crescita, più produttività, più risultati. Ma a questa moltiplicazione non corrisponde nessuna divisione reale dei benefici. Anzi: dividiamo responsabilità, dividiamo colpe, dividiamo i pochi servizi rimasti. La redistribuzione non avviene per scelta politica, ma come conseguenza delle fratture sociali.
E così ci ritroviamo con lavoratori e lavoratrici qualificati, laureati, che profumano al mattino per sedersi a una scrivania… ma non riescono a pagare l’affitto. Con bambini sovraccarichi di attività pomeridiane, ma poveri di tempo libero. Con famiglie che devono scegliere tra una visita privata e una lista d’attesa infinita.
La povertà non è più quella delle fotografie in bianco e nero: oggi ha una carta prepagata, forse una laurea, sicuramente poche garanzie. Serve una nuova grammatica sociale, e sì, anche una nuova aritmetica. Ma imparare a contare non basta. Serve anche imparare a correggere i conti sbagliati. Aristotele – che non a caso parlava di giustizia distributiva e giustizia correttiva – ci ricorda che l’indignazione per chi prospera senza merito (la nemesis) può essere un’emozione giusta, nobile, perfino educativa. Non tutto ciò che viene “guadagnato” è meritato. Non tutto ciò che appare “neutrale” è davvero equo. È nella capacità di aggiustare l’equilibrio tra chi ha troppo e chi ha troppo poco che si esercita una forma autentica di giustizia. Correggere, allora, diventa un’operazione sociale: ricalibrare, ridistribuire, ripensare. Perché a volte è proprio l’equazione iniziale a essere sbagliata – e riconoscerlo è il primo passo per costruire una società più giusta.
Il mito dell’aumento infinito è duro a morire: più crescita, più consumi, più tutto. Eppure, studiosi come Serge Latouche (2007) ci ricordano che non è detto che la qualità della vita cresca insieme al PIL. A volte il benessere si trova proprio nella sottrazione.
Sottrarre non è solo togliere: è fare spazio. Paolo Legrenzi (2021) distingue tra sottrazioni buone (razionali, produttive, semplificatrici) e sottrazioni cattive (tagli ciechi, semplificazioni pericolose). E oggi più che mai serve una società che sappia sottrarre con intelligenza.
Sottrarre il superfluo per lasciare spazio al necessario. Sottrarre l’ipercompetizione per sommare relazioni. Sottrarre il consumo compulsivo per sommare sostenibilità.
Non possiamo chiedere al singolo cittadino di risolvere tutto: è la società intera che deve ripensare le sue operazioni fondamentali.
Manuale elementare di giustizia sociale: Per imparare a contare le cose che contano davvero
A scuola ci insegnano che la matematica serve per orientarsi nella vita quotidiana. Ma forse non ci dicono abbastanza quanto possa servire per orientarsi anche nella vita collettiva. E allora eccolo qui: un manuale elementare di giustizia sociale, dove le quattro operazioni diventano strumenti politici.
- – Sottraiamo l’ansia da prestazione collettiva, + e sommiamo condizioni di vita dignitose per tutti.
- * Non moltiplichiamo lavoretti precari, : dividiamo le tutele e le garanzie in modo equo.
- – Sottraiamo test standardizzati e meccanici, +sommiamo tempo e cura per riconoscere le differenze tra gli studenti.
- – Sottraiamo investimenti in carbone e bonus auto,+ sommiamo fondi a trasporto pubblico, sanità e scuola.
- : Dividiamo i profitti straordinari, + sommiamo sicurezza economica per chi è più vulnerabile.
- – Rimuoviamo lo stigma sulla povertà,+ aggiungiamo narrazioni più vere e meno colpevolizzanti.
- – Sottraiamo la retorica del merito come unica misura, + sommiamo contesti, storie e disuguaglianze strutturali.
Esercizi di ripasso (con problemi veri)
Per chi volesse mettere alla prova le proprie competenze matematico-sociali, ecco una serie di esercizi ispirati ai classici problemi scolastici, ma basati sulla realtà. Valgono per studenti, docenti, decisori pubblici e cittadini attivi.
1. Quale operazione usiamo?
Una città riceve un finanziamento per la mobilità. Decide di costruire un nuovo parcheggio multipiano anziché potenziare il trasporto pubblico nei quartieri periferici.
Che operazione è stata fatta?
- A) Una moltiplicazione urbana (per pochi)
- B) Una divisione equa
- C) Una sottrazione mal calcolata
2. Risolvi il problema:
Giulia ha due lauree, tre contratti a tempo determinato negli ultimi due anni, e zero giorni di ferie.
Quanti diritti le mancano per arrivare a una condizione dignitosa?
3. Trova l’errore:
Il Ministero stanzia 1 miliardo per l’industria automobilistica e 200 milioni per la scuola pubblica.
Quale cifra va corretta affinché la somma generi un futuro sostenibile?
Scegli l’operazione corretta:
Un bambino fa 5 attività pomeridiane a settimana, tutte finalizzate allo sviluppo di competenze per “essere competitivo” a scuola. Ma non ha tempo per giocare con gli amici né per annoiarsi un po’.
Qual è l’operazione più giusta da fare?
- A) Moltiplicare ancora le competenze
- B) Sottrarre almeno due impegni e lasciare spazio al diritto al gioco
- C) Dividere meglio il tempo tra doveri e piaceri
5. Problema 1
In una città con un’alta percentuale di disoccupazione giovanile, vengono aperti 3 nuovi coworking privati con abbonamento mensile di 180 euro.
Contemporaneamente, viene chiuso un centro di formazione pubblica gratuita.
Quale operazione serviva davvero?
- A) Moltiplicare i servizi a pagamento
- B) Dividere i costi con fondi pubblici
- C) Sottrarre l’accesso gratuito alla conoscenza
6. Problema 2
In una scuola, viene introdotto un test standardizzato nazionale che determina i fondi per ciascun istituto. Le scuole con studenti più fragili ottengono meno risorse.
Qual è l’errore dell’operazione?
- A) La divisione è stata fatta senza equità
- B) La sottrazione ha colpito chi aveva già poco
- C) Entrambe le risposte sono corrette
7. Problema 3
Un Comune ha 1 milione di euro da investire. Destina 800.000 euro in appalti a privati per interventi edilizi che non rispondono a bisogni urgenti della comunità, lasciando solo 200.000 euro per biblioteche e presidi culturali di quartiere.
Come si può riequilibrare l’equazione?
- A) Moltiplicare i fondi pubblici per l’auto privata
- B) Sottrarre risorse ai parcheggi e sommarle alla cultura
- C) Lasciare tutto così perché “la cultura non porta voti”
8. Problema 4
Un’azienda tech sviluppa un’IA per selezionare personale. Il sistema esclude automaticamente i candidati con pause lavorative superiori ai 6 mesi. Il 90% delle escluse sono donne.
Dove avviene l’errore?
- A) Nella moltiplicazione cieca dell’efficienza
- B) Nella sottrazione di umanità dall’algoritmo
- C) In entrambe le operazioni
!!!! Suggerimento per educatori (di scuola o di coscienza civile):
Ogni problema ha più di una soluzione. Ma le risposte “sbagliate” sono quelle che lasciano tutto com’è.
Riferimenti bibliografici
- Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. In Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency.
- Latouche, S. (2007). Farewell to Growth. Polity Press.
- Legrenzi, P. (2021). La buona sottrazione. Il Mulino.
- Oxfam. (2024). Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality.
- Pew Research Center. (2023). STEM Curricula and Social Issues: A Global Comparison.
-

Psicologa-psicoterapeuta perfezionata in Psicologia dell'orientamento alle scelte scolastico-professionali e ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università di Padova. Docente di "Psicologia dell'inclusione e della sostenibilità sociale" e di "Career Counselling e orientamento professionale in contesto multiculturale". Dal 2009 collabora con il Laboratorio La.R.I.O.S. all'organizzazione e all'attuazione di progetti di orientamento, e alla realizzazione di ricerche relative al tema delle vulnerabilità, dell'orientamento e dell'inclusione lavorativa. È membro del comitato direttivo del Laboratorio La.R.I.O.S., vicepresidente della Società Italiana di Orientamento (SIO) ed è membro dell'Advisory Board dell'International Journal for Educational and Vocational Guidance. Attualmente è coordinatrice del progetto europeo Equi-T (sistema europeo di sviluppo della qualità per l'educazione inclusiva e la formazione degli insegnanti).